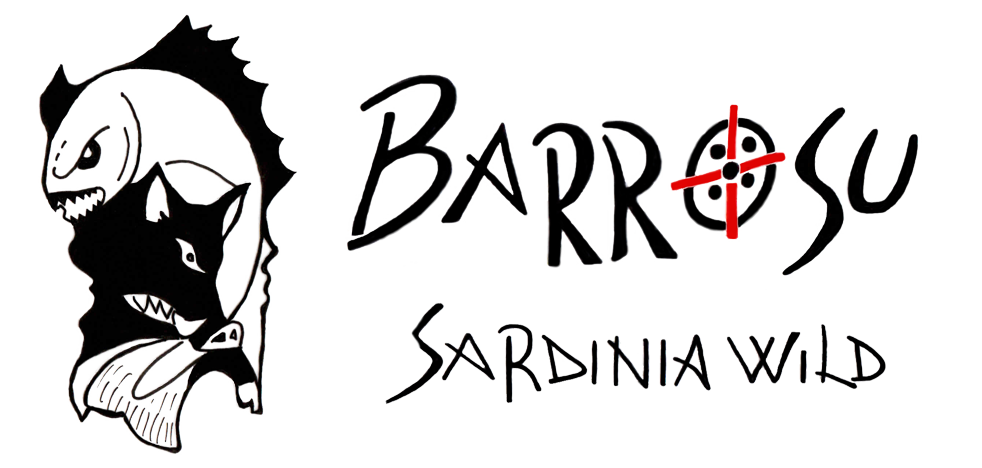Come si esca il Bigattino
Leave a comment
Non ci sono prodotti nel carrello.
Il BIGATTINO (CAGNOTTO) 3.0
E’ giunto il momento di parlare di un’esca su cui tutto è già stato detto ma che dobbiamo prendere in considerazione anche noi per l’importanza che riveste, soprattutto in questo periodo dell’anno.
Siamo in autunno inoltrato, il tempo si fa cupo, il mare mosso, ma la temperatura esterna e quella dell’acqua sono ancora elevate e garantiscono un’ottima vitalità alle larve, vitalità da cui dipende quasi interamente la loro capacità di attrarre le nostre prede.
Il bigattino non è un’esca particolarmente selettiva. Capita di prenderci un po’ di tutto e la selezione la fanno per lo più la zona e la tecnica di pesca. Assai gradito in superficie da spigole e lecce stella, risulta micidiale a mezzofondo per le occhiate e a fondo per gli sparidi più pregiati come saraghi e orate.
Le tecniche sostanzialmente sono il ledgering (per essere più precisi dovremmo parlare di “feeder”) e la bolognese sia nella sua interpretazione classica, che nelle forme miste che prevedono l’utilizzo di montature in stile inglese o l’ausilio del pasturatore scorrevole.
La scelta tra l’una o l’altra tecnica è dettata principalmente dal tipo di spot e dal pesce insidiato. Di solito ci regoliamo grossolanamente in questo modo:
Questo in linea molto generale, senza prenderlo come vangelo. E’ comunque evidente che su un fondale di pochi metri sia più logico pescare leggeri e pasturare manualmente (a manciate o fiondate a seconda della distanza da coprire), mentre la ricerca di grufolatori su un fondale di diversi metri richieda un sistema che entri velocemente in pesca e che trasporti altrettanto rapidamente la pastura sul fondo. La spiaggia è un spot particolare e, come abbiamo già avuto modo di dire, benché il ledgering sia la tegnica standard, la bolognese è sempre da prendere in considerazione se il fondale lo permette.
Tornando al bigattino in sé, esiste una nutrita serie di inneschi. Ne mostriamo alcuni tra i principali:
Bigattino singolo
Il bigattino innescato singolarmente è di sicuro la modalità di presentazione più naturale. Infatti, se si escludono le bocce di bigattini incollati, sia che si pasturi manualmente che si utilizzi un feeder le larve si disperdono nell’acqua una separata dall’altra e non a ciuffetti. Innesco ideale per pesci sospettosi come la spigola, richiede ami di misura molto ridotta (16-18), solitamente più piccoli di quelli utilizzati per l’innesco di larve a gruppo (14).
Bigattini in gruppo
Gli inneschi possono essere più o meno voluminosi (2-3 bigattini). Di base queste presentazioni sono più indicate per gli sparidi (saraghi, orate, occhiate).
Il BIGATTINO (CAGNOTTO) 2.0
Capita a volte di trovare nelle interiora dei pesci qualche bigattino vivo, ma sono quelle larve ingoiate dal pesce poco prima di essere allamato, per le quali i succhi gastrici non hanno avuto il tempo di compiere il loro lavoro. Basta guardare con più attenzione per trovare invece dei bigattini morti, probabilmente ingeriti abbastanza prima della cattura per i quali i succhi hanno fatto già il loro lavoro. Poiché questa diceria ha spopolato tra i pescatori, qualche buon ricercatore si è preso la briga di fare degli studi scientifici sull’argomento. L’organo che ha commissionato la ricerca è stato l’Anpre, (Associazione nazionale produttori rivenditori esche) con la supervisione scientifica dell’ Istituto di Zooculture dell’Università di Bologna. Il test è stato fatto sottoponendo alcuni pesci di allevamento, alimentandoli parte con pellets di farina di pesce e altri con il semplice bigattino, il tutto per 6 mesi. L’analisi delle acque effettuata ogni 15 giorni, ha sempre evidenziato la mancanza di azoto e di fosfati, una discreta quantità di ossigeno disciolto ed un ph neutro, mentre l’analisi del sangue effettuata su dieci pesci delle due differenti vasche, ha dimostrato che i parametri ematici, epatici ed enzimatici erano nella norma per i pesci allevati nella vasca del bigattino, e leggermente alterati negli altri. Il controllo bisettimanale dello stato di salute generale dei pesci (colore, sopravvivenza, dimensione e peso), ha dimostrato che gli esemplari allevati a pellet hanno avuto un incremento di peso leggermente superiore agli altri e la mortalità, in seguito ad una infezione da saprolegna, (una malattia cutanea che in genere contraggono gli avannotti negli allevamenti, che si manifesta solo in seguito a carico della pelle, sulla quale si manifestano delle escoriazioni a volte mortali) è stata leggermente inferiore negli esemplari allevati con bigattini, anche se non era possibile somministrare loro un cibo medicato come si è solito fare con i pellets. Non è mai stata riscontrata la presenza di bigattini ne di ferite nello stomaco dei pesci morti successivamente sottoposti ad autopsia. ( Tratto da Pescare Mare N°3, Marzo 2010).
Personalmente guardo alla larva di mosca carnaria come una efficacissima esca viva, che differisce dal gamberetto vivo solo per il fatto che la sua reperibilità risulta molto più immediata, dato che ogni negozio di pesca che si definisca tale ne ha quasi sempre una bella scorta nei suoi frigoriferi. Senza ombra di ogni dubbio il bigattino rende bene con tantissime specie ittiche che popolano le nostre coste, come ad esempio cefali, rigatini, ombrine, saraghi, anguille, orate, corvine e spigole.
Il BIGATTINO (CAGNOTTO) 1.0
Il bigattino si sviluppa da un uovo deposto dalla mosca carnaria sulla carne in putrefazione. La successiva fase di crescita del bigattino, riguarda la trasformazione che lo porta a diventare una pupa, il caster che viene utilizzato dai pescatori sia di acqua dolce che di acqua salata. Dopo questa fase il caster si schiude e diventa mosca. Numerosi studi medici hanno evidenziato come la larva di mosca non contenga, ne all’interno ne all’esterno sostanze nocive all’essere umano, eccetto per i soggetti allergici alla larva. La carica batterica del bigattino è infatti paragonabile a quella di qualsiasi altra esca viva. Per ciò che concerne invece la possibile emanazione di miasmi nocivi, va detto che le prove sperimentali condotte in laboratori specializzati, hanno evidenziato che l’esca in questione produce spontaneamente un secreto sterilizzante con funzione autoimmunitaria che gli permette di disinfettare la sostanza organica con cui viene a contatto, per un discreto raggio di superficie circostante. Il bigattino è un’esca che si conserva per lunghi periodi e, mentre d’estate si deve conservare in frigorifero (puzza un pò di amoniaca però), d’inverno è possibile conservarla in un luogo fresco ed asciutto. Una conservazione corretta della larva consiste, qualora decidessimo di mantenerla in frigorifero, di porla in un recipiente di plastica aggiungendovi della farina di polenta in modo da fare stare le larvette belle asciutte: come si evince, l’umidità è un nemico perchè innesca il meccanismo di trasformazione da larva in pupa. Cerchiamo per cui di tenere i bigattini belli asciutti.
La larva può essere innescata su ami del 12/14 con un bigattino infilato sul gambo dell’amo, e altri due o tre penzolanti. Si usa anche innescata su ami del 16/20, innescata singolarmente, per vincere la diffidenza dei pesci più grossi, ma molto sospettosi, che reputerebbero i tre quattro bigattini innescati come poco naturali nei loro movimenti. Un’ultimo possibile innesco che spesso si può rivelare risolutore, vede innescati più di quattro bigattini su di un amo del 10/8, la cosiddetta mazzetta. Una diceria riguardante tale esca, accusa i bigattini di divorare il pesce dall’interno o di attaccarli dall’esterno…..Quando peschiamo con la larva, solitamente la usiamo sia per pasturare sia sull’amo. Le larve gettate in mare che si depositano sul fondo, per alcuni minuti presentano una frenetica attività in acqua salata, nonostante essa si trovi fuori dall’ambiente abituale in cui cresce e vive. Il bigattino non è affatto una larva assalitrice, e si nutre per cui solo di organismi morti, per cui è letteralmente impossibile che attacchi la fauna ittica, specialmente in un ambiente naturale che non è il suo. Per ciò che concerne invece il fatto che divori i pesci dall’interno una volta che è stata ingerita, è totalmente fuori discussione poiché nello stomaco dei pesci c’è una cosuccia chiamata succo gastrico che distrugge le larve nel normale processo di digestione.
Il bibi è un verme, anche piuttosto grosso, della famiglia dei Sipunculidi. Si presenta come un piccolo grissino con la pelle rivestita di una cuticola quadrettata.
E’ di colore biancastro, trasparente da giovane, bruno scuro da adulto. L’interno è pieno di un liquido trasparente che tende a fuoriuscire nell’innesco. La sua lunghezza massima è anche oltre il mezzo metro e rappresenta un’esca micidiale dalla spiaggia, soprattutto per Saraghi, Orate e Ombrine. Gli ami adatti sono a curvatura larga, tipo gli Aberdeen, e con un piccolo anello per favorire l’innesco. Si trovano in commercio sia sfusi che in confezioni. Il suo nome scientifico è “sipunculus nudus” e fa parte della famiglia dei sipunculidi.
Il nome comunemente usato bibi deriva dal francese Bibi che sembra significhi “cappellino da signora”, anche se per la sua forma ricorda più qualcosa di fallico, seppur piccolo.
Negli States, invece, i vermi vengono denominati “peanuts worms” grazie alla consistenza quadrettata della pelle esterna. Le misure effettive variano da 2 mm a 35 centimetri, e le specie presenti in natura sono oltre 320, e tutte marine, di cui circa una diecina presenti nel Mediterraneo.
Questi piccoli vermi vivono interrati nel fango o nella sabbia dove formano piccole gallerie. Fanno parte degli anellini e si distinguono da quest’ultimi per la totale assenza di setole e segmentazione. Alcuni tipi, invece, si fermano tra rocce e gusci di Gasteropodi. A volte a seguito di forti mareggiate vengono piaggiati, mentre altri bibi sono stati trovati anche a superfici di qualche migliaio di metri.
Il bibi ha anche il sesso, e la fecondazione è esterna. Il corpo è munito di una piccola “proboscide” più sottile rispetto al tronco. Alla fine di essa si trova la bocca che è circoscritta da una serie di piccoli tentacoli. Grazie alla vita statica riescono a vivere molti anni ed il sistema nervoso è ridottissimo. Non hanno sistema circolatorio e apparato respiratorio. Non hanno quindi sangue. Attraverso la superficie della pelle scambiano i gas con l’esterno. In fase di fecondazione il maschio libero lo sperma che stimola a sua volta le femmine a liberare le uova. Durante il primo mese si ha la fase larvale planctonica, seguita da uno stadio larvale bentonico. Scava buchi profondi anche 50 cm nel fango e nella sabbia. Per catturare le particelle organiche utilizzano il muco che riveste i tentacoli, oppure ingeriscono i sedimenti trattenendo solo piccolissimi microrganismi e particelle organiche. Viene pescato con le turbo soffianti utilizzate per la pesca dei bivalvi.
Il bibi risulta essere un’esca molto interessante, che può risultare vincente soprattutto con tre speci ittiche molto pregiate quali: orata, spigola e ombrina ma non viene disdegnata anche da mormore e saraghi di grossa taglia.
Il bibi si può conservare sia da vivo che da morto. Da vivo, ha una longevità pari alle cure che avremo nel mantenerlo. Ideale è una temperatura di circa 16° C, cercando di ottimizzare l’umidità del luogo in cui vive, attraverso poca acqua di mare da applicare alla spugna, alla sabbia o qualsiasi altro materiale che decideremo di utilizzare come base per il suo pernottamento.
Tecnica di pesca: in mare, pesca a fondo dalla costa (Surf Casting); Bolentino in fondali molto alti
Ami: a curvatura larga
Inneschi: intero o a pezzi, a calza o a fisarmonica
Periodo di impiego: tutto l’anno ed in particolare di notte e nei mesi da Settembre a Febbraio.
IL VERME AMERICANO
Una tipologia di esca per la pesca al mare conosciutissima dai pescatori italiani, l’ americano è un verme da pesca molto utilizzato grazie alle sue caratteristiche attrattive dei pesci.
L’ americano ha una lunghezza variabile ma la sua forza è il suo sangue, infatti è un verme molto sanguinolento e proprio questa caratteristica lo rende un esca molto appetitosa per molti pesci di mare.
Di colore marrone rossastro si trova nel mediterraneo ma molto difficile da scovare, proprio per questo viene venduto da società di esche da pesca ed è abbastanza caro.
Come innescare l’ americano
Questo verme è innescabile sia con l’ ago, in modo tale da non perdere il suo fluido attirante ma si può innescare anche a pezzi, specialmente negli esemplari più grandi, facendo sempre attenzione a non svuotare il verme dal suo fluido corporeo.
Uno dei vermi anellidi più utilizzati nella pesca a fondo e nel surfcasting è sicuramente il verme americano. Quest’ultimo risulta micidiale per pesci come orate, spigole, saraghi e mormore.
Inoltre è un verme abbastanza resistente al lancio e non troppo gradito alla minutaglia per via della sua grandezza.
L’innesco di questo verme può creare, soprattutto ai meno esperti, diversi problemi anche perchè è dotato di due dentini aguzzi che nel caso di esemplari di taglia grande (i cosiddetti XXL) può addirittura provocare dei piccoli e fastidiosi taglietti sulle dita.
Provo a spiegarvi come faccio io per innescarlo senza problemi.
Innanzitutto premetto che è indispensabile l’utilizzo dell’apposito ago da innesco.
Per prima cosa faccio si che tiri fuori la sua bocca biforcuta, in quel momento faccio una leggerissima pressione sui lati di essa impedendogli così di richiuderla; con molta delicatezza gli infilo l’ago in bocca dalla parte bucata facendolo passare per tutto il corpo fino a meno di un centimetro dalla fine della coda; ora appunto l’amo all’ago e, sempre con la massima cautela, faccio scorrere il verme sull’amo e sulla parte finale del terminale; lascio che la testa sia libera di muoversi lasciando la punta dell’amo scoperta. Il gioco è fatto!
Sottolineo che è molto importante eseguire con la massima attenzione questa procedura perchè dobbiamo assolutamente impedire che il verme perda il suo sangue, che rappresenta il maggiore attirante per i pesci.
IL VERME KOREANO
Il coreano, al giorno d’oggi, è una tra le esche più diffuse e utilizzate dai pescatori sportivi italiani, forse per merito delle numerose circostanze di applicazione che offre, o magari per merito del prezzo di mercato piuttosto contenuto rispetto a quello degli altri anellidi adatti per la pesca in mare.
Dalla bolognese al beach ledgering, dal feeder al surfcasting, dalla pesca a fondo a quella di galla … è in tutte queste tecniche che il coreano può essere utilizzato, spesso in alternativa alle esche “tradizionali”.
Ma dove risiede davvero il potere attrattivo di questo anellide? Sicuramente nel vivace movimento che è in grado di “offrire” a lungo, quando questi, ovviamente, è innescato in un modo tale da consentirgli di muoversi liberamente; è per questo motivo che viene denominato anche “saltarello”.
Due sono le specie più diffuse e commercializzate come esche: il coreano (che possiamo definire) “classico”, di colore verde scuro sul dorso e rossastro sul ventre, e il coreano rosso, dalla livrea uniforme, più adatto per il beach ledgering e il surfcasting a causa della sua forte visibilità una volta sul fondale sabbioso.
Risulta essere un’esca apprezzata da diverse specie ittiche: primi fra tutti i pesci di galla (come lecce stella, sugarelli, piccoli saraghi, aguglie e occhiate) quando il nostro coreano è innescato assieme ad un piccolo pezzo di schiuma pop up; spesso risulta essere discretamente catturante nei confronti di alcuni grufolatori come mormore, grugnitori e piccole orate; talvolta anche le giovani spigole, più voraci e aggressive, cedono al vivace movimento di questo verme.
Molteplici sono le modalità d’innesco del coreano, a seconda della tecnica utilizzata, ma tutte sono tese a ledere il meno possibile la vitalità dell’esca, con l’obiettivo di non comprometterne il movimento una volta che questa viene posizionata in acqua.
In quelle tecniche di pesca che prevedono l’utilizzo di un galleggiante, il coreano viene innescato appuntandolo sulla bocca con ami di piccole dimensioni.
Questo risulta essere un tipo di innesco prevalentemente indirizzato alla spigola, in quanto simula un vero e proprio avannotto di anguilla (frequentemente predati dai branzini che si stabiliscono o transitano nelle foci e nei bassi corsi dei fiumi).
Per quelle tecniche di pesca che prevedono lanci piuttosto sostenuti, è necessario che il coreano vada a calzare per intero l’amo, lasciando soltanto la “coda” (si intendono gli ultimi 2-3 cm del corpo) libera di muoversi, per meglio resistere ai lanci stessi.
E’ fondamentale che venga utilizzato un ago per trasferire la nostra esca sull’amo (meglio se un Aberdeen) a partire dalla coda.
In questo modo sarà la testa a ricadere sulla punta dell’amo, evitando fastidiosi scivolamenti del verme stesso. Può essere innescato a pezzi, utilizzando soltanto la coda (quando si preferiscono inneschi meno voluminosi), o “cucendolo” sul nostro terminale con l’ausilio dell’amo che lo trapasserà in più punti.
Spesso, durante le nostre sessioni di pesca, non riusciamo a consumare tutte le confezioni di esche acquistate; il coreano risulta essere, a differenza di altre, di facile conservazione purchè venga riposto in un ambiente piuttosto fresco (10 gradi circa) e moderatamente umido.